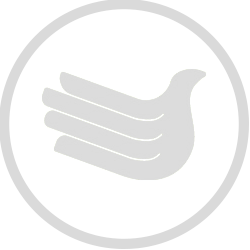Osteopatia Ricerca osteopatica
Il nuovo modello biopsicosociale in medicina: l’unico possibile per aiutare i pazienti

di Nicola Barsotti, Marco Chiera, Diego Lanaro
Il concetto di “paradigma” in ambito scientifico venne proposto per la prima volta da Thomas Kuhn, filosofo con una formazione in fisica, nel libro “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”.
Dai suoi lavori emerge che il contesto socio-psicologico in cui i ricercatori si formano e lavorano è centrale nell’orientare la ricerca poiché questa non è data da individui isolati, ma da gruppi di professionisti che hanno ricevuto la stessa educazione e seguono gli stessi modelli di ricerca (ciò che Kuhn chiama “dogmi condivisi”) (Kuhn 1962).
Ne consegue che l’insieme di questi apparati cognitivi costituisce quella che Kuhn chiama “scienza normale”, in cui i problemi che il paradigma non risolve vengono classificati come “eccezioni” da ricondurre alle regole conosciute.
La “scienza normale” e la “scienza straordinaria”
Tutto ciò ci dice almeno due cose: primo, lo scienziato non è un “super-osservatore” che studia i fenomeni senza esserne coinvolto (questa è la tipica visione positivista di inizio ’800 che, incredibilmente, è ancora molto presente oggi);
secondo, se esiste una “scienza normale”, deve esserci anche una “scienza straordinaria” (Abbagnano & Fornero 1993).
Riassumendo, in pratica in ogni fase storica gli scienziati si riconoscono all’interno di teorie che costituiscono il proprio paradigma, cercando di renderle sempre più articolate.
Nel procedere della scienza, però, avvengono spesso scoperte che non possono essere spiegate dalle teorie di riferimento. Anzi, tali scoperte possono anche falsificare le teorie stesse. Ne consegue che il paradigma dominante viene mandato progressivamente in crisi (pensiamo a Giordano Bruno e Galileo Galilei, Newton, Einstein, etc.). Si avvia così quel periodo di scienza “straordinaria”, segnato da intuizioni anche extra-scientifiche (vedi Einstein) che entrano in conflitto con la “scienza normale” e che generano scontri.
Nel tempo, tramite progressive falsificazioni, la comunità scientifica tende quindi a “convertirsi” al nuovo paradigma in grado di spiegare meglio i dati di ricerca “straordinari”. A questo punto, nasce un nuovo periodo di scienza “normale” ed il ciclo si chiude.
Ne consegue che, secondo Kuhn, l’evoluzione della scienza non avviene in modo progressivo, come molti ritengono, ma attraverso strappi radicali e repentini rispetto al pensiero dominante (Kuhn 1962).
Con il cambio di secolo, in campo bio-medico stiamo assistendo a questo cambio di paradigma, passando dall’approccio “riduzionistico” a quello della “complessità”.
A sancire tutto questo è stato il New England Journal of Medicine, in un articolo pubblicato nel 2012, in cui si sostiene che il sistema medico dominante ha portato a costi insostenibili, scarsità di risultati, frequenti errori medici, scarsa soddisfazione sia del medico che del paziente. Le cause, per gli autori, dipendono dal fatto che il modello di riferimento si era strutturato per la cura di patologie acute su pazienti per la maggior parte giovani. Nei decenni sono però apparse patologie sempre più croniche che affliggono pazienti sempre più anziani. L’approccio “ortodosso”, quindi, non è stato più in grado di gestire in modo efficace la malattia e la salute poiché si è concentrato su patologie acute (es.: infezioni) e non ha approfondito l’origine complessa e multifattoriale di quelle croniche. Di conseguenza, il modello medico fallisce nel prevenire l’insorgenza delle malattie e tende a medicalizzare i fattori di rischio, perdendo di vista la salute della persona e il suo legame con la vita quotidiana (Marvasti & Stafford 2012).
Per far fronte a questa situazione, al paradigma riduzionista sta subentrando quello biopsicosociale, introdotto dal professor George L. Engel in un articolo che ha fatto la storia della medicina e che fu pubblicato sulla prestigiosa rivista Science (Engel 1977). Engel sostiene che per comprendere lo stato di salute o di malattia di una persona è necessario considerare non soltanto l’aspetto biologico ma anche quello psicologico e sociale, a partire dal contesto nel quale la persona nasce e cresce.
Grazie a ciò, con il cambio di secolo, abbiamo avuto rivoluzioni in vari settori della medicina: in neurologia oggi si parla di network cerebrali, sinapsi complessa e modulabile, plasticità cerebrale, neurogenesi; in biologia di epigenetica e meccanobiologia; l’immunologia è vista come studio dei sistemi di regolazione interna; in psicologia si parla di neurobiologia; nel settore delle terapie manuali si parla di tessuto connettivo come struttura unificante che connette strutturalmente tutto il corpo e che ha effetti meccanochimici, biochimici, fisiologici, psichici; in fisiologia e patologia si parla di PNEI, psiconeuroendocrinoimmunologia (Bottaccioli & Bottaccioli 2017).
Traducendo tutto questo in clinica, dobbiamo parlare di “integrazione”: vedere la persona nella sua interezza. Ogni paziente dovrebbe avere pertanto una diagnosi integrata in grado di combinare indagini e valutazioni biologiche, psicologiche e biomeccaniche nel quadro di un esame della sua biografia (come tra l’altro tratta un articolo molto recente in cui si evidenzia che, ad esempio, negli esami sanguigni i valori di riferimento dovrebbero essere individualizzati sulla storia della singola persona; Walt 2019).
Bibliografia
Abbagnano N. e Fornero G. (1993), Filosofi e filosofie nella storia, vol.3, Torino, Paravia.
Bottaccioli F. E Bottaccioli AG (2017), Psiconeuroendocrinoimmunologia, il manuale, Milano, Edra Elsevier.
Engel G.L. (1977), The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine. In Science 196:4286 129-36.
Kuhn T. (1962), La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Milano, Einaudi.
Marvasti F.F. and Stafford M.D. (2012), From Sick Care to Health Care — Reengineering Prevention into the U.S. System. In The New England Journal of Medicine, 367:10 889-91.
Walt D.R. (2019), Clinical testing should be individualized, not based on populations. Journal of Clinical Investigation [Epub ahead of print].